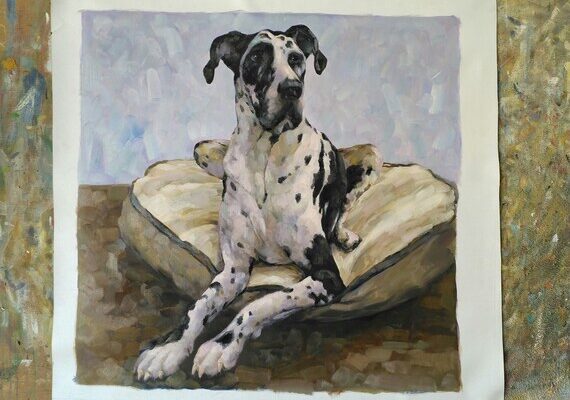Il Ministero della Salute ha prorogato l’ordinanza contingibile e urgente del 6 agosto 2013, n. 209 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. La variante, rispetto alle precedenti versioni, pare essere l’inserimento, di mera completezza compilativa delle norme.
Il fondamento della necessità di prorogare l’ordinanza è indicato nella volontà di adottare misure di precauzione a tutela dell’incolumità pubblica, vulnerata da «frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari».
Il primo comma dell’art. 1 si riferisce al rapporto uomo-animale e alla duplice posizione di garanzia del primo: nei confronti del cane, per il suo benessere, e nei confronti di terzi, per i danni provocati dagli animali. Anche il secondo comma rimanda alla responsabilità del detentore. Seguono, al terzo comma, indicazioni di buon senso sulla gestione dei cani: informazioni, affidi consapevoli, guinzaglio, museruola. Il quarto comma si dedica alle deiezioni canine: igiene e buon senso.
Il quinto comma, che prevede percorsi formativi attivati da Comune e ATS che culminano con il rilascio di un c.d. patentino, appare il più innovativo.
Incarichi informativi vengono attribuiti dal comma sesto ai medici veterinari che informano gli interessati della possibilità di fare percorsi formativi e dovrebbero segnalare all’autorità sanitaria pubblica i cani che richiedono una valutazione comportamentale. Infine, il settimo comma impone la frequenza di corsi formativi ai proprietari di cani che si siano resi responsabili di episodi di morsicatura, aggressione o, non meglio definiti, “altri criteri di rischio”.
Completamente dedicato ai divieti è l’art. 2, tra i quali spicca l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività, la sottoposizione di cani a doping, le operazioni di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività.
All’art. 3 l’ordinanza stabilisce che, fermo quanto previsto in materia di prevenzione della rabbia, i servizi veterinari attivano un percorso per verificare le condizioni psico-fisiche del cane e della corretta gestione da parte del proprietario. I servizi, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico.
Occorre, inoltre, la formazione di un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, a cura dei servizi veterinari: i proprietari di tali cani devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e hanno l’obbligo – in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – di guinzaglio congiunto a museruola.
Gli animali inseriti in tale registro non possono essere posseduti o detenuti da soggetti particolari: delinquenti abituali o per tendenza, sottoposti a misure di prevenzione personale o di sicurezza personale, chi abbia riportato una condanna per delitto contro la persona o il patrimonio, se punibile con la reclusione fino a due anni, chi sia stato condannato per reati contro gli animali.
Tuttavia, l’art. 5 prevede che le disposizioni non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, da un lato, né ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia di greggi e a conduzione di greggi, dall’altro.